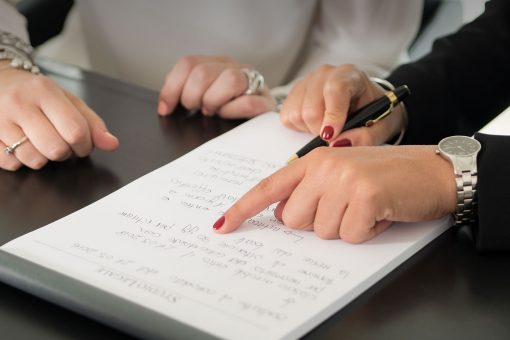I 10 passaggi necessari per poter partecipare alle nuove vendite immobiliari con modalità telematiche.
La Legge n. 119/2016 ha modificato l’Art. 569 comma 4 c.p.c., stabilendo che le vendite immobiliari nell’ambito delle procedure esecutive si svolgano con modalità telematiche.
Tale disciplina ha trovato applicazione per le procedure esecutive in cui è stata disposta la vendita in data successiva al 10 aprile 2018.
Il tribunale di Firenze nella scelta delle modalità da seguire per la vendita telematica ha scelto la modalità “SINCRONA” caratterizzata dalla simultanea connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti alla data ed ora indicata nell’offerta di vendita, con possibilità di rilanci esclusivamente in via telematica.
Di seguito i passaggi da seguire per acquistare un immobile mediante un’asta telematica:
SCELTA DELL’IMMOBILE per il quale si intende presentare un’offerta di acquisto: mediante l’accesso ai seguenti siti internet (www.asteimmobili.it – www.astalegale.net – www.portaleaste.com – www.publicomonline.it – www.isveg.it) è possibile selezionare – anche mediante l’inserimento di filtri – le unità immobiliari in vendita, prendendo visione della relativa documentazione, in particolare:
la perizia predisposta dal consulente tecnico nominato da Tribunale contenente la descrizione dell’immobile, la regolarità urbanistica e il prezzo a base d’asta;
la documentazione fotografica e le planimetrie;
l’avviso di vendita predisposta dal professionista delegato dove viene indicata la data e l’ora in cui si svolgerà l’asta, previa apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto.
ACQUISIZIONE CASELLA PEC: è necessario dotarsi di una casella pec identificativa, come previsto dal DM n° 32 del 26 febbraio 2015. In mancanza di una casella pec sarà necessario avvalersi di un professionista per la presentazione dell’offerta, il quale agirà all’interno del portale delle vendite per conto dell’offerente quale mero “presentatore”.
REGISTRAZIONE sul sito www.spazioaste.it come persona fisica o come persona giuridica.
VERSAMENTO CAUZIONE a garanzia dell’offerta di importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto. Il pagamento deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nell’avviso di vendita, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’apertura delle buste. Qualora la cauzione non risulti accreditata sul conto della procedura al momento dell’apertura della busta, l’offerta verrà esclusa.
PREDISPOSIZIONE OFFERTA per la partecipazione alla vendita telematica è necessario cliccare sul pulsante “crea nuova busta” sul portale www.spazioaste.it e procedere con la compilazione dei moduli inserendo tutte le informazioni richieste e caricando la documentazione necessaria:
Documento d’identità offerente
autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di offerta presentata per conto di un minore;
permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di offerta presentata da soggetto extracomunitario;
certificato CCIAA aggiornato (non più di 10 giorni), in caso di offerta presentata da società;
prova del pagamento del bollo virtuale da euro 16,00;
prova del versamento della cauzione.
Qualora l’offerta venga presentata da soggetto diverso dall’offerente (“presentatore”) si precisa che detto soggetto, può presentare una sola offerta per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita.
INVIO OFFERTA a mezzo pec. Il sistema consente di scegliere fra le seguenti tre opzioni:
Opzione 1: “pec con attestazione in allegato” è necessario allegare l’attestazione dell’avvenuta identificazione da parte del Gestore di Pec rilasciata al soggetto proprietario della casella.
Opzione 2: “pec con attestazione in calce al messaggio”: l’attestazione di avvenuta identificazione del soggetto proprietario della casella pec è automaticamente inserita in calce nel messaggio di posta elettronica certificata. È necessario verificare con il proprio fornitore di PEC la presenza di tale attestazione all’interno del messaggio.
Opzione 3: “Pec + firma digitale” è necessario procedere sottoscrivendo digitalmente tutta la documentazione allegata alla busta.
Se l’operazione di firma della documentazione è andata a buon fine viene visualizzato il messaggio “la documentazione è stata caricata e firmata con successo”. Per completare l’invio della propria offerta di partecipazione alla vendita sarà necessario cliccare sul pulsante “Genera e invia la busta”.
APERTURA BUSTE da parte del professionista delegato nel giorno e all’ora indicati nell’avviso di vendita. Gli offerenti hanno la possibilità die verificare in tempo reale la validità della propria busta tramite l’aggiornamento automatico dello stato e dell’esito dell’esame dell’offerta.
Dopo la verifica delle buste viene aperta la gara telematica durante la quale è possibile effettuare i rilanci al fine di risultare il miglior offerente e potersi aggiudicare il bene posto in asta.
Allo scadere del tempo, se non ci saranno offerte migliorative rispetto all’ultima pervenuta, si concluderà l’asta. Lo stato della procedura di vendita segnerà la dicitura “Terminata” identificando a video il “miglior offerente”
PAGAMENTO del prezzo offerto in caso di aggiudicazione. All’esito dell’asta il professionista delegato provvederà a mettersi in contatto con l’aggiudicatario per tutte le informazioni relative al pagamento del saldo prezzo (differenza fra il prezzo offerto e la cauzione che viene trattenuta sul conto corrente della procedura). Tale pagamento dovrà avvenire nel termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione e potrà essere eseguito anche mediante contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura con accesso a un contratto di finanziamento o subentro nel contratto di finanziamento originariamente stipulato dal debitore esecutato.
Oltre al prezzo offerto devono essere considerati le seguenti spese:
imposta di registro o imposta sul valore aggiunto ove dovuta;
imposte ipotecarie e catastali;
50% compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene (compreso fra 500,00 e 1.000,00 oltre accessori di legge).
IMMISSIONE NEL POSSESSO DELL’IMMOBILE mediante consegna delle chiavi da parte del custode, dopo l’apposizione della firma al decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’esecuzione (indicativamente non oltre 30 giorni dal pagamento del saldo prezzo)
POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLA GARA: secondo le indicazioni offerte dal Tribunale di Firenze la partecipazione alle operazioni di vendita potrà essere autorizzata esclusivamente al debitore, ai creditori ed agli eventuali comproprietari dell’immobile.